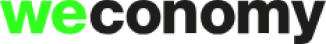Alla ricerca dell’identità degli spazi di lavoro
Quando i luoghi di lavoro diventano ibridi, è importante riprogettare gli uffici, per farne luoghi che aprano le menti e che connettano con gli altri.
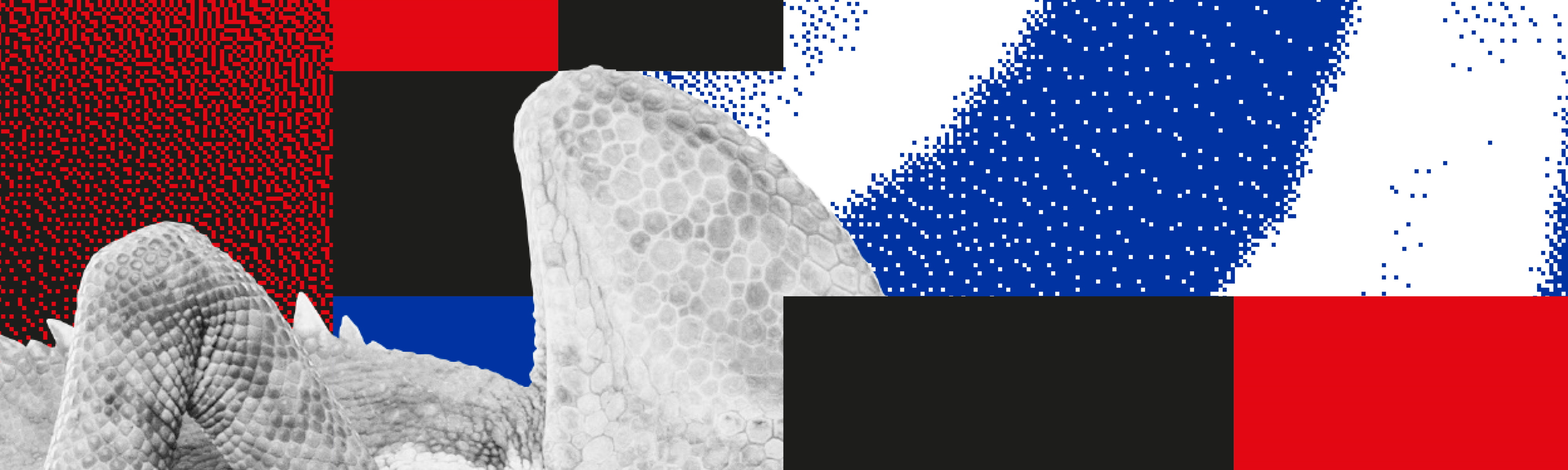
Quando i luoghi di lavoro diventano ibridi, è importante riprogettare gli uffici, per farne luoghi che aprano le menti e che connettano con gli altri.
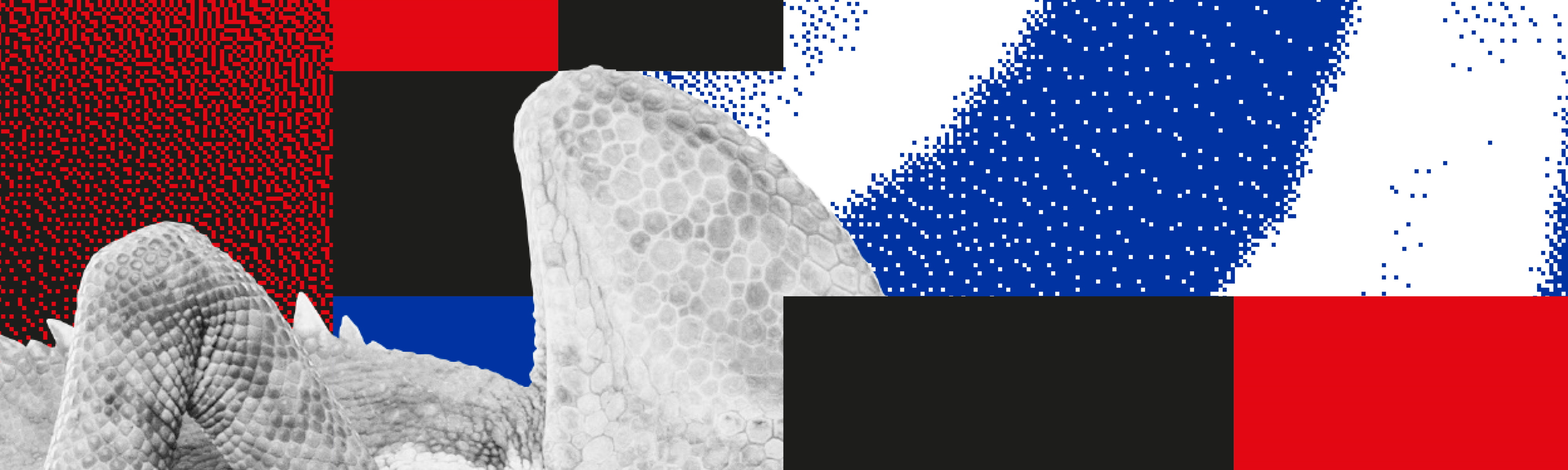
C’è qualcosa che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi senza vederlo, e che è improvvisamente tornato tangibile grazie a un virus. È la “dimensione nascosta” – dal titolo di un saggio del 1966 in cui l’antropologo E.T. Hall definì le basi della “prossemica” – in cui siamo costantemente immersi e che in modo silenzioso plasma ogni nostro comportamento privato, pubblico, sociale e professionale molto più di quanto pensiamo. E di cui ci siamo appunto accorti quando è venuta a mancare, come ogni cosa invisibile ma essenziale. È lo spazio.
Lo spazio influisce a livello biologico sul nostro umore e la nostra salute e rappresenta, allo stesso tempo, un segnale simbolico del tipo di rapporto che stiamo intrattenendo con gli altri, ci parla del nostro disagio o del nostro benessere relazionale, della nostra disponibilità o chiusura, della nostra manifestazione di fiducia o di sfiducia agendo sui nostri comportamenti e sulla loro comunicazione. “Lo spazio parla, e parla anche quando non vogliamo ascoltarlo”, sostiene E.T. Hall. Ebbene in questi ultimi anni ci ha parlato eccome.
“Distanziamento”, “assembramento”, “numero chiuso”, “lockdown”, lavoro a “distanza”: è il lessico diventato familiare a causa della pandemia, di fatto ridefinendo il nostro rapporto individuale e sociale con lo spazio e le sue regole d’uso, la sua accessibilità, la sua funzione pratica, ma anche il suo significato simbolico e il suo valore economico. Schemi e abitudini consolidate sono cambiati improvvisamente costringendoci a misurarci con case da trasformare in scuole o uffici improvvisati, o palestre, con spazi riadattati o da ridefinire o ad accesso ridotto, con nuove distanze sociali e personali, con diverse esigenze di mobilità, con spazi pubblici deserti e spazi domestici affollati, gente in fuga dalle città in cerca di più spazio o anche solo di un balcone più ampio e vivibile.
Abbiamo provato sulla nostra pelle come trovare un equilibrio sia una questione di quantità (meno spazio hai, più diventa difficile adattarlo a esigenze che cambiano) ma anche di qualità: gli spazi mal progettati o non progettati affatto, o pensati per altro, non abbastanza flessibili né accoglienti, la mancanza di spazio adeguato o dello spazio “giusto” possono generare un’infinità di problemi, individuali o collettivi: frustrazione, disagio, improduttività, depressione o persino il collasso di un’intera organizzazione. E si è aperto un diffuso dibattito su come gli spazi, domestici, lavorativi, urbani dell’imminente futuro andrebbero d’ora in poi immaginati.
Di evoluzione in quest’ambito si parlava però già da alcuni anni: “We shape our buildings; thereafter they shape us” (“plasmiamo i nostri edifici, e dopo loro plasmano noi”). Era la frase di apertura attribuita a Winston Churchill con cui un articolo di Wired a fine 2018 analizzava il tema del futuro degli spazi di lavoro. Il Covid-19 era ancora lontano, ma un’evoluzione inevitabile nel modo di pensare/progettare/realizzare/vivere gli spazi destinati alla dimensione lavorativa era già suggerita da una serie di fattori sempre più impattanti: innovazione tecnologica esponenziale, cambiamenti demografici (nuove generazioni con nuovi gusti ed esigenze), diffusione di strumenti digitali sempre più potenti e accessibili, il ruolo sempre più centrale dell’impatto ambientale, nuovi modelli di mobilità urbana ed extra-urbana.
Il grande statista aveva senz’altro ragione: lo spazio in cui trascorriamo il nostro tempo sia esso il classico “ufficio”, o un qualsiasi altro spazio – come le nostre case – adattato all’uso per necessità, può trasformare la nostra esperienza quotidiana in modo anche drastico. Ha un impatto sul clima lavorativo, sulla produttività, sull’efficienza, sul benessere psicofisico, sulle relazioni interpersonali, persino sull’appeal che la nostra organizzazione riesce a esercitare verso nuovi talenti o candidati, in una competizione in cui, soprattutto per le nuove generazioni, il fattore di attrazione principale non è più necessariamente, o non solo, lo stipendio.
“Devi creare un’esperienza di lavoro ottimale per tutti i dipendenti, indipendentemente dal loro ruolo, mandato o esperienza, al fine di trattenerli”, affermavano i manager di WeWork (ex leader mondiale dei co-working prima dell’istanza di fallimento in USA e Canada). Per di più il tema dell’attrattività si è incrociato e sovrapposto a quello del “ritorno alla normalità” post-covid, e l’office-home balance è diventato il nuovo terreno di gioco del work-life balance e di molto altro che vi ruota intorno.
Sull’argomento c’è una enorme produzione di ricerche e articoli, che testimoniano posizioni polarizzate ma con molte sfumature in mezzo: tra i nuovi “nomadi digitali” o i fautori della YOLO Economy (You Only Live Once), che rifiutano ormai il concetto stesso di ufficio e di lavoro tradizionale, e coloro che invece hanno sofferto il lavoro in remoto e vorrebbero un ritorno al passato, si allarga la moltitudine di quelli che preferirebbero una soluzione mista in cui poter alternare le due formule in maniera flessibile. Mentre si aspetta che questo momento di transizione si allontani lentamente nello specchietto retrovisore, molti leader aziendali guardano al futuro, applicando le lezioni apprese alle sfide che ci attendono. Al centro di queste sfide ci sarà dunque il luogo di lavoro, sia gli spazi virtuali che quelli fisici, e il loro aspetto post-pandemia.
Sia chiaro, il Coronavirus e le sue conseguenze, come stiamo vedendo nella post-pandemia, non elimineranno gli uffici. Semmai, li renderanno più dinamici che mai. La capacità di lavorare da remoto non allontanerà la maggior parte delle persone definitivamente dalle città e dalle sedi usuali, ma consentirà a molti di vivere e lavorare in nuovi modi e luoghi, causando quindi una forte disruption del sistema precedente.
Ma l’identità di un luogo comune, come collante sociale tra persone, rimane irrinunciabile. Non è un segreto che gli scambi a livello virtuale non siano in grado di sostituire l’esperienza di integrazione fisica. Una chiacchierata estemporanea con un collega in corridoio, un incontro casuale alla macchinetta del caffè o il riunirsi con gli altri di persona per condividere traguardi e obiettivi. Per loro stessa natura, questo tipo di interazioni informali casuali non possono essere programmate o imposte nell’agenda e, di conseguenza, sono difficili da replicare online. Questo tipo di capitale sociale è molto più difficile da generare tra individui che si sono incontrati solo tramite una chiamata Zoom o una riunione su Teams.
Le organizzazioni dovrebbero quindi poter garantire due requisiti chiave: uno è soddisfare il bisogno emotivo dei dipendenti di lavorare in gruppo, mentre l’altro è fornire loro le condizioni adeguate in termini di infrastrutture e spazi per svolgere i propri compiti secondo modelli nuovi.
I migliori spazi saranno quelli che conserveranno il potere di aprire le nostre menti, connetterci con gli altri e incoraggiare la collaborazione. Con un design mirato, una densità ponderata, la disponibilità di tecnologie per il lavoro misto remoto/presenza, un’illuminazione invitante, spazi di incontro e relax, e non ultima una forte integrazione di materiali naturali e verde, come secondo gli ultimi dettami del “design biofilico”.
Quest’ultima è una filosofia progettuale che architetti sempre più numerosi – da Norman Foster a Carlo Ratti fino a Kengo Kuma – propongono di utilizzare per ridisegnare il futuro attraverso un nuovo equilibrio con la natura. Proprio l’architetto giapponese realizzerà a Milano quello che è considerato uno dei complessi più innovativi al mondo in quest’ambito, avvalendosi della collaborazione di Stefano Mancuso, botanico di prestigio mondiale. Gli elementi naturali nell’architettura, come vegetazione, luce, aria e legno stimolano i sensi e fanno la differenza sul posto di lavoro, sullo stile di vita e migliorano la salute fisica e mentale, oltre che la produttività.
Certo, è pur vero che l’80% degli uffici è già costruito e solo una piccola parte potrà essere modificata o ristrutturata. Ciò significa che i cambiamenti che vedremo sul breve termine dovranno riguardare soprattutto comportamenti e tecnologie, il modo in cui utilizziamo e abilitiamo lo spazio. Pensare che i cambiamenti strutturali domineranno il ripensamento degli uffici semplicemente non è fattibile dal punto di vista dei costi, della sostenibilità o delle capacità di realizzazione. Ma volendo riassumere, saranno cinque le principali azioni da non perdere di vista per restare al passo:
1. Creare luoghi che siano hub per la collaborazione più che luoghi di rappresentanza.
2. Disegnare spazi ed esperienze dall’identità forte in grado di attrarre e trattenere le persone.
3. Offrire un mix di ambienti per il lavoro informale ma che garantiscano benessere e relax.
4. Investire nell’innovazione tecnologica.
5. Diminuire l’impatto ambientale e inserire il più possibile la natura negli ambienti di lavoro.

Pubblicato su Weconomy 15 – UFO. Unidentified future organizations