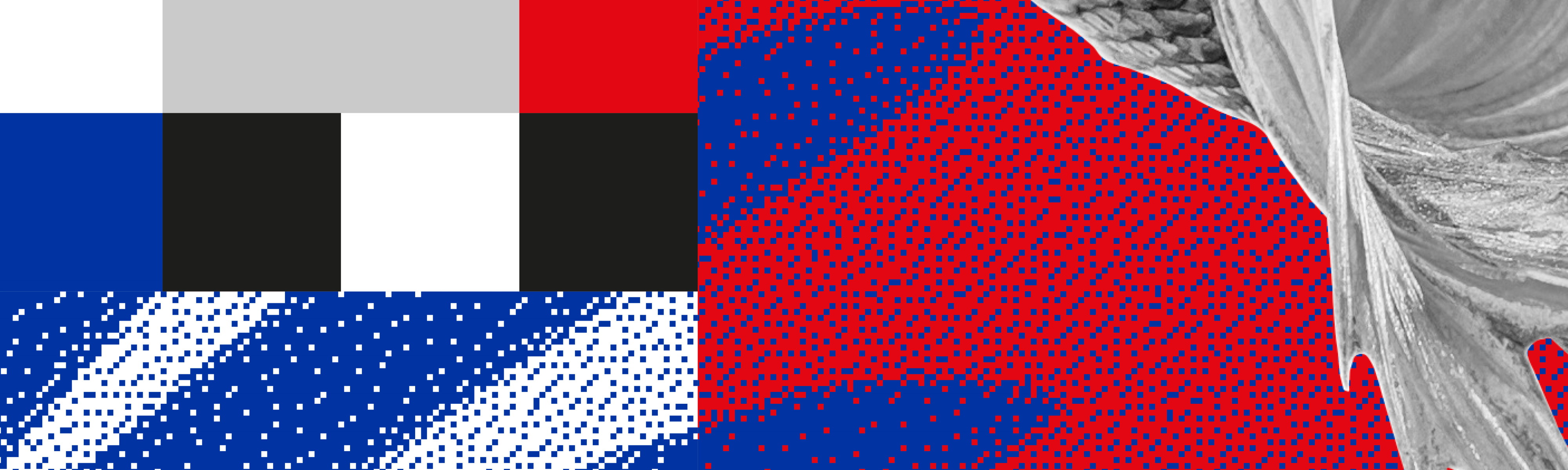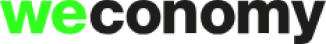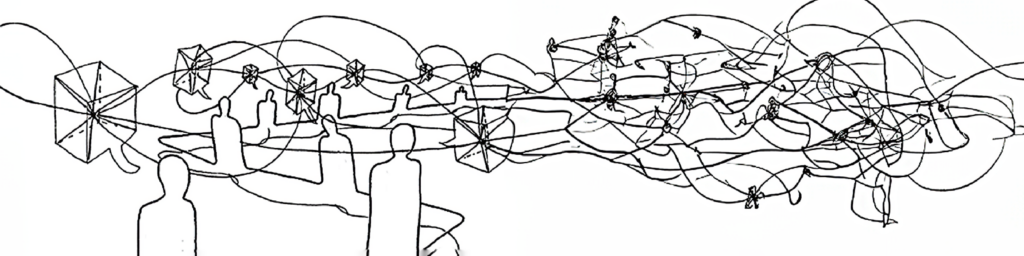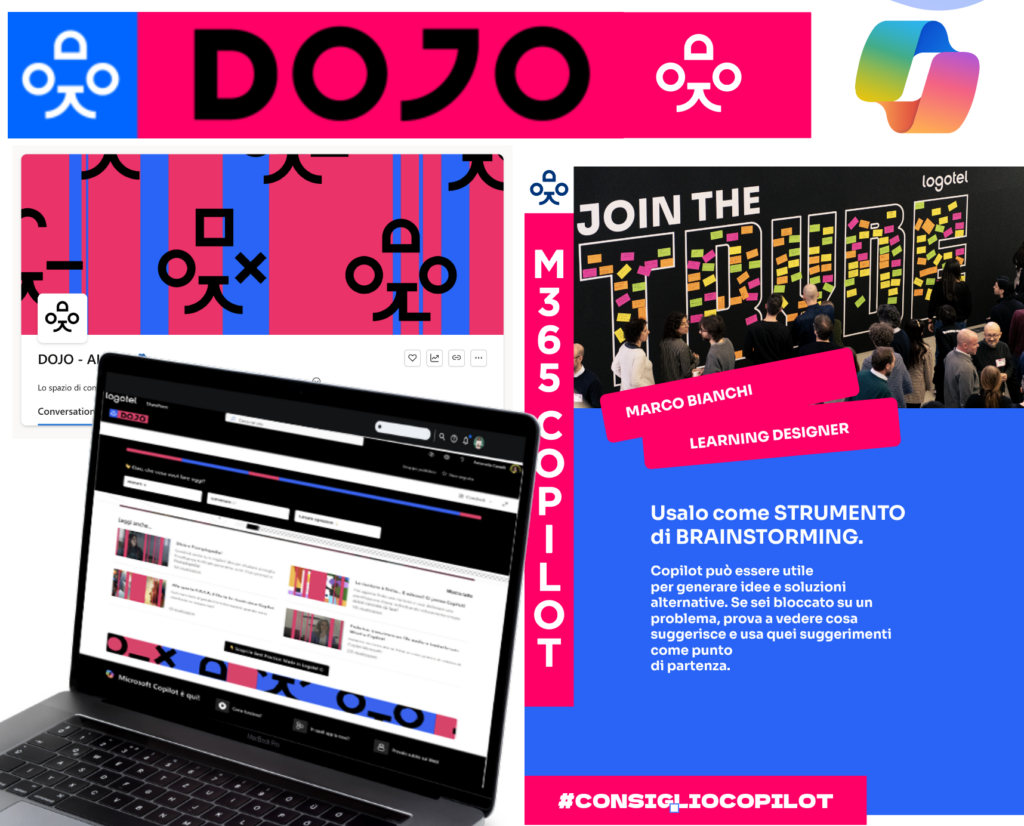Dopo gli anni di smart working emergenziale, stiamo vivendo una fase di normalizzazione, che ci spinge a riflettere sul concetto di alienazione. Perché finora ci è parso sufficiente assoggettare il lavoro online a quell’agenda digitale sulla quale piazzare le riunioni o a quei tool con cui portare a termine le attività. Pensiamo sia una impostazione da resettare, perché esclude la complessa rete di relazioni che ci permette di spaziare ed essere creativi.
Il digitale è un ambiente da vivere, non un medium da sfruttare
Non dobbiamo pensare che queste nuove forme di alienazione siano frutto di un disegno consapevole. E quindi inevitabili. Sono il risultato di un approccio che inquadra il digitale come se fosse medium tradizionale da sfruttare. E non come ambiente da vivere. La differenza è enorme. La stessa che passa tra guardare in tv una stancante replica della programmazione estiva e prender parte a un videogame con miriadi di mondi. I medium tradizionali, infatti, ci impongono la semplificazione, per veicolare contenuti monodirezionali che annoiano in fretta e, perciò, hanno bisogno di tenere alta l’attenzione in un intervallo di tempo limitato. Ci spingono inoltre a puntare tutto sull’intrattenimento e la leggerezza perché, una volta che lo schermo si spegne, l’esperienza finisce. Ecco quale può essere la discontinuità più profonda tra il lavoro online, come lo abbiamo inteso finora, e una nuova visione in cui anche se non succede niente sugli schermi, accade qualcosa.
Il dominio degli strumenti e l’illusione della produttività
Forse ci siamo concentrati troppo sugli strumenti da adottare (le board, le suite, il cloud) e sul dove usarli (a casa o in room attrezzate), senza tener conto che – nella nostra storia di esseri umani – siamo noi ad aver adattato gli oggetti ai nostri propositi. Tant’è che, quando si parla di innovazioni e tecnologie, l’antropologo André Leroi-Gourhan distingue tra tendenze tecniche e fatti tecnici. Le prime sono universali, come l’invenzione della ruota. E forse l’avanzare delle nuove modalità di lavoro rientra in questo caso. I secondi variano in base ai contesti: le ruote non hanno dovunque gli stessi raggi, né sono fatte degli stessi materiali. E così, gli strumenti, i luoghi e i tempi necessari a far funzionare lo smart working non saranno uguali per tutti. Ma come scegliere i più adatti a noi?
E se avessimo avuto solo l’illusione di essere più produttivi?
Forse abbiamo partecipato involontariamente a un gioco a somma zero. Abbiamo avuto l’illusione di lavorare meglio invece c’era qualcos’altro che lavorava per noi: appunto, gli strumenti digitali. Sono i tool che hanno raggiunto il massimo potenziale – e le piattaforme di collaborazione lo hanno registrato senza tentennamenti: sono aumentate le ore di riunioni digitali e sono cresciuti i file salvati online. Ma tutto ciò non può essere il metro della produttività.
Perché, guardando bene i dati, ci accorgiamo che, se prendiamo in considerazione la produttività oraria, scopriamo che è scesa. Insomma, abbiamo solo lavorato per più tempo ogni giorno, come documenta l’Economist nell’articolo “Remote workers work longer, not more efficiently“. E questa inefficienza nascosta è in parte responsabile delle varie forme di burnout, della perdita di flessibilità e di qualità. Certo, abbiamo imparato a utilizzare qualcosa di nuovo ma, forse, è una forma di apprendimento che ha mancato il suo obiettivo, perché si è concentrata totalmente sull’oggetto. È ciò che accade quando scopriamo qualcosa di nuovo: tutti i nostri sforzi sono concentrati sulla tecnica. E raggiungiamo la gratificazione quando arriviamo a padroneggiare il nuovo. Forse allora dobbiamo iniziare a chiederci: cosa possiamo fare di diverso con i nuovi strumenti? E se gli strumenti non fossero la prospettiva dalla quale partire?
Gli effetti dell’accelerazione sulle organizzazioni
Abbiamo letto molto spesso che il Covid-19 è stato un acceleratore: per esempio ha velocizzato l’apprendimento delle competenze digitali e ha fatto crescere l’e-commerce, imponendo un riadattamento in tutto l’ecosistema retail. Ma l’antropologo Thomas Hylland Eriksen, nel suo libro “Fuori controllo“, fa notare come, nell’era dei “cambiamenti accelerati”, stiamo perdendo la flessibilità. Gli ambienti che abitiamo sono super-differenti e super-complessi. Ci sono tanti (troppi?) attori in gioco, troppe variabili. E la concatenazione estrema di cambiamenti che stiamo vivendo può irrigidirci e rallentare le decisioni, perché una sola variabile impazzita potrebbe rompere l’intero sistema. Ed è ciò che temono i manager oggi. Perché le organizzazioni sono complesse e stratificate.
Il rapporto tra aumento della complessità e perdita della flessibilità ci invita a riflettere sulla scala con la quale guardiamo alle organizzazioni. È insormontabile solo se guardiamo un’impresa nel suo insieme, come un unico mega-organismo. Questa prospettiva porta a farci domande limitanti come: se introduco un cambiamento il sistema reggerà? Quali sono i rischi che sono disposto ad affrontare per evitare che si rompa? Crediamo che oggi siano interrogativi da mettere da parte, perché le organizzazioni non sono monolitiche, si compongono di tanti piccoli elementi flessibili, con una grande capacità di adattamento: per esempio i singoli, i team, le comunità di persone che condividono esperienze e aspirazioni.
Tra fratture e connessioni
Eppure non è così semplice. Perché questo cambiamento è nato da un trauma. Il Covid-19 ha toccato la nostra carne, ha impattato sulla sicurezza fisica e psicologica. In molti casi ha richiesto decisioni laceranti, anche da parte degli imprenditori che hanno lasciato a casa persone. Ha dato nuove possibilità ad alcuni (di cucinare in maniera sana, di godersi la propria casa con giardino, di tenersi in forma e avere più tempo per i propri figli) e tolto qualcosa ad altri (a chi non ha famigliarità con il digitale, a manager il cui stile e carisma erano fondati sulla presenza fisica, ad attori in ecosistemi che improvvisamente si sono bloccati, come il turismo e la cultura).
La pandemia ha anche generato nuove connessioni
Sono nate fratture e divisioni che non è sufficiente ricomporre. Perché durante le fasi di transizione il senso di inadeguatezza è la dimensione psicologica prevalente: non ci sono più modelli di riferimento. Ma può iniziare una fase di scoperta ed esplorazione. Perché nulla è come sembra. La pandemia ha anche generato nuove connessioni. Ci ha mostrato le possibilità di un nuovo ecosistema di relazioni. Basta guardarsi intorno. In un periodo in cui molte delle conquiste acquisite ci sono state negate per la nostra sicurezza (come la libertà di movimento), sono nati network informali di auto-aiuto. Di fatto sono emersi meccanismi che alimentano le comunità, in cui gli scambi utilitaristici (per esempio verso chi aveva bisogno di beni essenziali, magari confinato in quarantena) sono serviti alla sopravvivenza della nostra dimensione sociale. Ciò non significa che gli esseri umani siano diventati migliori. Anzi abbiamo imparato quanto siano fragili i legami che abbiamo visto nascere. Di fatto però è cambiato qualcosa in noi. Anche sul lavoro, nella fase di distanza forzata, abbiamo sperimentato nuove forme di colleganza, in grado di sopravvivere nella distanza. E che, forse, possono essere un punto di partenza per alimentare il contesto organizzativo di quelle organizzazioni che possiamo definire UFO, Unidentified future organizations. Le organizzazioni del futuro: reticolari, diffuse, distribuite, che abbiamo analizzato da vari punti di vista nel 15° numero di Weconomy, progetto di ricerca open source di Logotel.